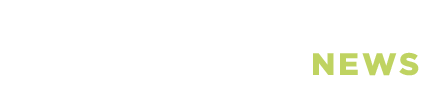In occasione della Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico, l’evento organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da Fondazione Inarcassa, è stata diffusa la Nota “Dissesto idrogeologico: migliorare la programmazione per uscire dall’emergenza”, a cura del Centro Studi del CNI e del Centro Studi del CNG, con alcuni dati di sistema che aiutano ad inquadrare la questione del rischio idrogeologici e degli interventi necessari.
Gli investimenti per contrastare il rischio idrogeologico
“Per gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nel Paese sono stati stanziati e resi disponibili 20,1 miliardi di euro negli ultimi 25 anni, per un totale di 25.795 interventi (ammessi a finanziamento ma non sempre realizzati) distribuiti sul territorio nazionale. Una parte molto consistente dei finanziamenti è stata stanziata negli ultimi anni. Nel periodo 2020-2024 infatti lo Stato ha reso disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico 10 miliardi di euro sulla base di quanto emerge dalla Piattaforma Rendis gestita da Ispra”, si legge nella Nota.
“Questo a fronte di una spesa per riparare i danni che dal 2012 al 2023 è praticamente triplicata raggiungendo 3,3 miliardi l’anno. Tale valore è destinato, purtroppo, a salire ulteriormente.
Trattandosi di opere spesso pluriennali, il tasso di realizzazione può essere valutato solo per gli interventi realizzati più indietro nel tempo. Se infatti si considerano gli stanziamenti che vanno dal 1999 al 2011, nel complesso l’ammontare di investimenti riguardanti le opere concluse supera il 70% di quanto stanziato. Se si guarda agli anni più recenti, ovviamente, il tasso di completamento è molto più basso, in quanto occorre dare il tempo che la progettazione si concluda e che le opere vengano realizzate. In linea generale il tasso di realizzazione appare apprezzabile ma non privo delle ben note criticità che riguardano tutte le opere pubbliche, ovvero tempi lunghi di “attraversamento” necessari ad autorizzazioni e controlli delle Amministrazioni preposte e periodi di progettazione che, il più delle volte, risultano più lunghi del periodo necessario per avviare e chiudere il cantiere.
La parte più consistente degli investimenti stanziati dallo Stato è destinata alle regioni con gli indici di pericolosità più elevati: il 9% risulta assegnato alla Calabria, il 7,9% alla Sicilia, il 7,9% al Veneto, l’8,3% alla Lombardia, il 6,5% all’Emilia-Romagna ed il 6,3% alla Toscana.
La maggiore quota di finanziamenti per interventi di mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico proviene attualmente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che contribuisce, infatti, per ben il 48% degli stanziamenti programmati negli ultimi 25 anni, seguito dal Ministero dell’Interno (31,1%) e poi dal Dipartimento della Protezione Civile (15,2%). Quote minori, ma comunque consistenti, provengono dal Ministero per l’Agricoltura, dalle Regioni e dal Dipartimento Casa Italia.
Gli eventi per i quali finora si è maggiormente intervenuti con finanziamenti pubblici hanno riguardato le frane (31,2%) e le alluvioni (28,7%), anche se il 33% si è sostanziato in interventi misti di mitigazione, prevenzione e riparazione da danni”.
Il problema non è finanziario ma organizzativo
Dai dati disponibili pare emergere che “nel nostro Paese non vi sia un sostanziale problema di carenza di risorse per interventi attraverso cui affrontare i fenomeni di dissesto idrogeologico. Solo negli ultimi 4 anni, come detto, è stata reperita una dotazione di quasi 10 miliardi di euro e nel corso degli ultimi 25 anni sono stati programmati quasi 26.000 interventi.
Rispetto ad alcuni anni fa, infatti, le difficoltà registrate in merito all’attuazione degli interventi sono più organizzative che finanziarie: spesso le risorse ci sono, non vengono spese interamente e realizzate in tempi lunghi perché non collegate a progetti cantierabili, basate su ipotesi progettuali che poi vengono disattese sia per cambi di indirizzo politico che per difficoltà autorizzative.
I ritardi nella realizzazione delle opere sono quelli che accomunano tutto il sistema delle opere pubbliche italiane, ritardi generati più da complessità di tipo burocratico che da questioni legate eminentemente alla progettazione e, forse, ancor meno alla realizzazione dei lavori.
Dato l’ampio sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico è possibile affermare che il livello di attenzione al problema nel nostro Paese è elevato.
Ciò nonostante il Paese sembra ormai caratterizzarsi per una allerta permanente. È sufficiente citare alcuni eventi molto recenti: dal 2022 si contano almeno 3 eventi alluvionali gravi che hanno coinvolto le Marche, 6 eventi alluvionali con danni ingenti che hanno coinvolto ampi territori dell’Emilia-Romagna, un evento grave in vaste aree del Piemonte ad aprile 2025 oltre all’alluvione distruttiva di Ischia nel 2022. Questo solo per citare i fatti più impressivi e forse tristemente noti”.
Migliorare la governance nell’uso delle risorse finanziarie
Secondo la Nota, per andare più alla radice del problema occorrerebbe considerare due elementi. Anzitutto, “la presenza nel nostro Paese di un sistema di governance delle risorse e degli interventi che pur realizzato da enti competenti richiederebbe un maggiore coordinamento”. Inoltre, "è necessario aggiornare le modalità e gli strumenti di programmazione degli interventi, anche avvalendosi dei più recenti apparati di monitoraggio e di telerilevamento estremamente efficaci e che consentirebbero di aggiornare di continuo e migliorare le modalità di intervento puntuale sul territorio, non tanto e non solo in casi di emergenza (quando l’evento dannoso si sta verificando o si è già verificato), ma anche in via preventiva".