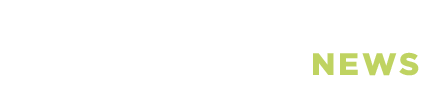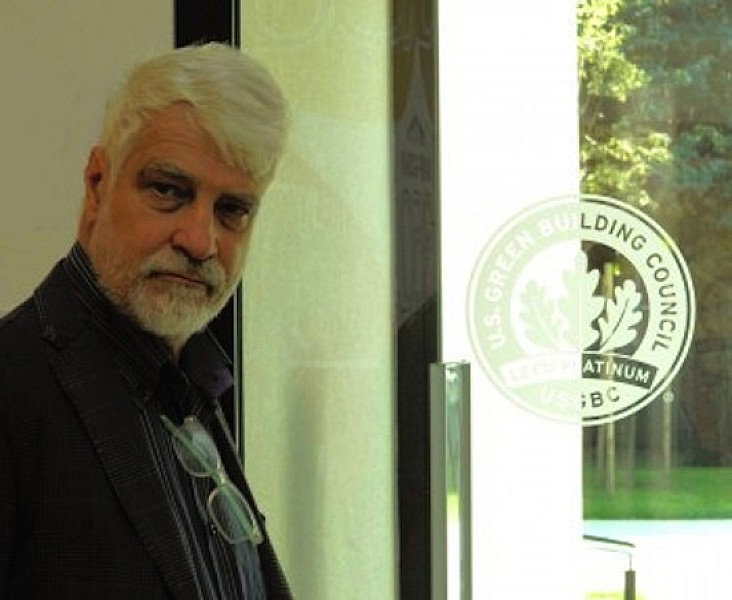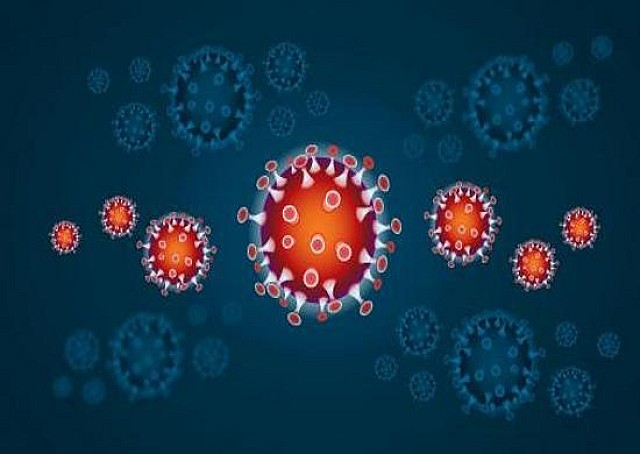Gianni Silvestrini* presenta su Il Giornale dell'Ingegnere un importante contributo per comprendere i temi oggetto della conferenza sul clima COP21 di Parigi che si apre oggi alla presenza di 150 capi di Stato.
Occhi puntati su Parigi dove, dopo i tragici fatti dei giorni scorsi, alla Conferenza delle Parti sul clima (COP21), si dovrebbe definire l’accordo che sostituirà il Protocollo di Kyoto, con l’importante novità del coinvolgimento di tutti i paesi del pianeta e non solo di quelli industrializzati. In effetti, 150 nazioni hanno già inviato come previsto i loro obiettivi di contenimento delle emissioni. Per la prima volta quasi tutti i paesi (mancano al momento solo i produttori di petrolio arabi) hanno dunque definito un proprio percorso di contenimento della CO2.
Dall’analisi dei documenti inviati si può già dare un primo giudizio: gli esiti della COP21 saranno al tempo stesso ambiziosi e sottostimati. Ambiziosi, perché solo un anno fa l’adesione della Cina, che ha un livello di emissioni superiore a quello di Usa e UE messe insieme, era tutt’altro che certa (l’accordo Usa-Cina sul clima è dell’11 novembre 2014). Ma riteniamo anche che alcuni impegni sottostimino i risultati ottenibili: in paesi di strategica importanza, parliamo ad esempio di Cina e India, le riduzioni reali saranno infatti probabilmente ben più consistenti di quelle dichiarate. In ogni caso, anche utilizzando le proposte inviate a Parigi, le emissioni pro-capite al 2030 sarebbero inferiori del 9% rispetto al 1990. In termini complessivi le 54 miliardi di tonnellate di gas climalteranti al 2030 rappresenterebbero però un incremento del 47% rispetto al 1990 e del 17% rispetto al 2010. La strada da fare, come si vede, è ancora molta.
Ma, quale sarebbe l’incremento di temperatura a fine secolo considerando gli obiettivi contenuti nelle dichiarazioni pervenute? L’accelerazione imposta dalla necessità di mettere la carte in tavola prima di Parigi potrebbe consentire di ridurre di 0,9 °C l’incremento di 3,5 °C stimato l’anno scorso. Cioè se tutti gli impegni annunciati verranno rispettati l’aumento a fine secolo sarà di +2,7 °C rispetto al 1750. Non siamo ancora ai 2 °C che sarebbero necessari per evitare un esito catastrofico dei cambiamenti climatici, ma si intravvede finalmente un percorso globale di controllo delle emissioni. Tanto più che diverse analisi fanno ritenere che l’irruzione di “disruptive technologies” come il fotovoltaico o i veicoli elettrici consentirà di accelerare la decarbonizzazione di alcune importanti economie. Prendiamo il caso della Cina che si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni nel 2030. La rapidità dei cambiamenti in atto, segnalati dal taglio del 6% del consumo di carbone nella generazione elettrica negli ultimi 12 mesi, consentirà probabilmente di anticipare la riduzione delle emissioni climalteranti già tra il 2020 e il 2025. L’accelerazione in atto è visibile anche in altri settori dell’economia cinese, come esemplifica la proposta di realizzare punti di ricarica elettrica in tutti i nuovi edifici per facilitare la gestione di 5 milioni di auto elettriche al 2020 o le nuove installazioni fotovoltaiche che nei primi nove mesi di quest’anno hanno raggiunto, mal grado il rallentamento dell’economia, i 9,5GW con un incremento del 161% rispetto all’anno precedente.
E un’analoga riflessione vale per l’India dove stanno decollando impressionanti programmi di crescita delle rinnovabili. Ma anche sul fronte dei paesi più virtuosi si moltiplicano le decisioni volte a rendere sempre più incisive le riduzioni di gas climalteranti. E’ il caso della Danimarca e della Svezia che hanno deciso di diventare totalmente “fossil free”, o della California che entro il 2030 punta ad avere il 50% della elettricità da rinnovabili e a raddoppiare i risparmi di energia negli edifici.
E non va dimenticato il ruolo fondamentale che potrà essere svolto dalle città. Sono almeno tre decenni che migliaia di Comuni di tutto il mondo sviluppano scenari, elaborano programmi e mettono in atto iniziative per ridurre le emissioni. Uno sforzo che ha visto un’accelerazione negli ultimi anni e che verrà potenziato dal raggiungimento di un accordo a Parigi. Lo stesso si può dire per il progressivo coinvolgimento del mondo delle imprese. Nel mondo sono infatti ormai più di 1.000 le grandi società che effettuano le loro scelte, o lo faranno nei prossimi due anni, considerando il valore delle emissioni di CO2. L’interiorizzazione del prezzo del carbonio nella definizione delle strategie interne anticipa le scelte politiche dei governi verso un’estensione dei programmi di scambio delle emissioni o verso l’introduzione di una carbon tax. Quest’ultima misura è stata auspicata da più istituzioni, dalla Banca Mondiale all’Agenzia Internazionale dell’Energia, ma ha bisogno di tempo affinché si creino le condizioni politiche per una sua applicazione su larga scala.
E veniamo all’Italia. Dopo la corsa delle rinnovabili elettriche, che nel 2014 hanno garantito la copertura del 37,5% della domanda, si sta assistendo ora ad un rallentamento della crescita. E’ comunque probabile che alla fine del prossimo decennio anche nel nostro paese come in diverse altre realtà europee si supererà la soglia del 50% dei consumi elettrici, grazie anche all’abbinamento di fotovoltaico ed accumulo.
Ma il settore che potrebbe rivelare le maggiori sorprese è quello dell’edilizia. Come si sa, le detrazioni fiscali hanno garantito buoni risultati negli interventi di riqualificazioni energetiche, con il limite però di applicarsi a singoli appartamenti e di non coinvolgere il settore pubblico. Il taglio delle emissioni europee al 2030 del 40% rispetto al 1990 implica un salto di qualità nelle politiche nel settore civile. Si dovrà elaborare una Roadmap che indichi un percorso di riqualificazione spinta, con riduzioni dei consumi del 60-80%, di interi edifici e quartieri. Si tratta cioè di definire una strategia in grado di aprire questo enorme mercato e di riavviare un comparto, quello dell’edilizia, in profonda crisi. Non è un percorso scontato e il suo avvio prevede la messa a punto di diversi elementi che vanno dalla definizione di specifici strumenti di incentivazione all’aggregazione dei comparti industriali interessati in modo da fornire risposte adeguate, ridurre i costi e abbreviare i tempi. Come esempio stimolante, applicabile anche in alcuni contesti italiani, va citata l’esperienza olandese Energiesprong di industrializzazione della riqualificazione che ha consentito di creare un modello di business in grado di effettuare interventi radicali azzerando i consumi, grazie anche all’abbinamento del fotovoltaico. I risultati sono stati impressionanti con case riqualificate in una sola settimana. Il tutto senza incentivi ma con il coinvolgimento di banche, assicurazioni, utility e con uno sforzo delle imprese del settore che si sono reinventate. Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi quattro anni, con 200 appartamenti riqualificati nel 2014 e 2.000 previsti per quest’anno, i costi si sono ridotti del 40%.
Visto il successo dell’operazione, esperienze analoghe stanno partendo nel Regno Unito, in Francia e anche nel nostro paese. Una spinta in questo senso potrebbe venire nel 2016 dal nuovo Conto Termico che prevede incentivi del 65% per la riqualificazione energetica spinta dell’edilizia pubblica. Un’ottima opportunità per sperimentare soluzioni innovative di retrofit industrializzato.
Tornando a Parigi, è dunque sperabile che l’accordo determini un’accelerazione a livello mondiale delle politiche sull’efficienza e sulle rinnovabili, centrali per ottenere le necessarie radicali riduzioni di emissione. In particolare, l’obiettivo europeo del taglio del 40% delle emissioni climalteranti al 2030 è articolato in una riduzione del 43% rispetto al 2005 per i settori energivori assoggettati all’ETS e in una riduzione del 30% per gli altri comparti. Nel 2016 verrà decisa la ripartizione tra i 28 paesi europei della quota del 30%, ma già sappiamo che occorrerà incrementare decisamente gli sforzi, visto che con le politiche attuali la riduzione delle emissioni alla fine del prossimo decennio sarebbe solo del 20%.
- Presidente Green Building Council Italia e Kyoto Club - articolo tratto da Il Giornale dell'Ingegenre n.11/2015 - Quine Business Publisher