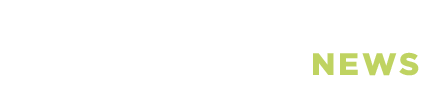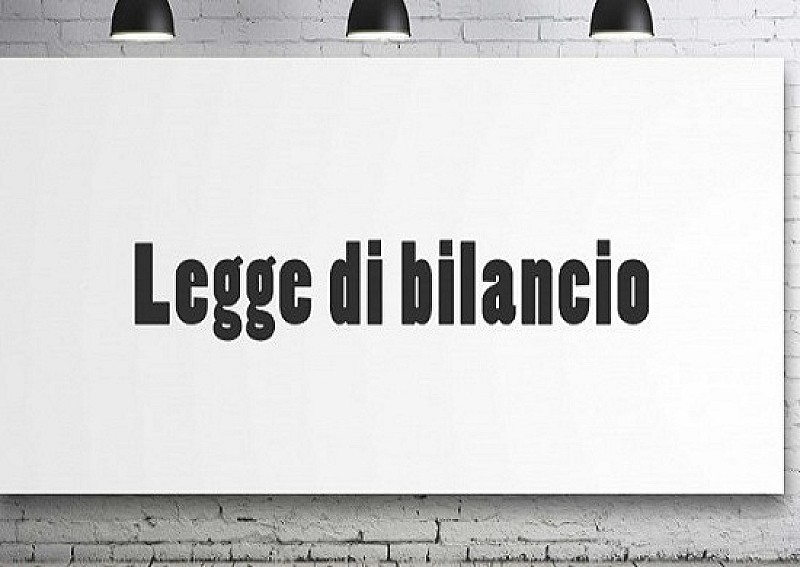Nel ddl Bilancio 2026, presentato al Senato, spunta una disposizione concernente l'eventuale nullità dell’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato.
La disposizione in questione si trova al comma 13 dell'articolo 129 (Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa), e così recita: “L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica”.
Il successivo comma 14 stabilisce che “La disposizione di cui al comma 13 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
La sentenza n. 23093/2025 della Cassazione
Ricordiamo che il problema della rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione Civile (Sez. U) nella lunga sentenza n. 23093/2025 (in allegato) pubblicata l'11 agosto.
“Il problema della rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare non può dirsi recente”, ha ricordato la suprema Corte nella predetta sentenza. “Se per il diritto romano classico la rinuncia alla proprietà degli immobili era compresa nella più ampia facoltà di derelictio, discutendosi soltanto se oltre la volontà del proprietario e l’effettivo abbandono della cosa occorresse altresì l'occupazione del bene da parte di un terzo, il diritto moderno ha preso ad interessarsene essenzialmente per condizionarne la validità ad una dichiarazione in forma scritta da rendere pubblica mediante trascrizione (ad esempio, art. 1314, n. 3, del codice civile 1865) o, nelle legislazioni di tipo germanico, mediante iscrizione nei libri fondiari.
Già oltre un secolo fa, si affermava in dottrina che la rarità dei casi in cui potesse avvenire una rinuncia del titolare alla proprietà di un immobile giustificava che l’ordinamento civilistico ne limitasse la disciplina alla previsione di specifiche formalità, senza curarsi di regolare più nel dettaglio tale modo di dismissione, pur avvertendo che detta rinuncia serve a soddisfare l’esigenza, tutt’altro che infrequente, di disfarsi di fondi la cui gestione risulti non soltanto infruttuosa, ma anche dannosa.
È questa la situazione che sembra accomunare le due vicende oggetto dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di L’Aquila e al Tribunale di Venezia. Gli immobili su cui vertono le due cause risultano sottoposti a vincoli conformativi della proprietà privata finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico alla stabilità e alla difesa dell’assetto idrogeologico del territorio, il che comporta la prescrizione di limiti ed obblighi alle rispettive facoltà dominicali”.
Nelle memorie depositate il 14 maggio 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio espongono che al momento sull’intero territorio nazionale risultano istruiti n. 128 affari legali connessi alla c.d. rinuncia abdicativa (dei quali n. 89 pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e n. 39 in fase stragiudiziale).
Dalla Cassazione due principi di diritto
La giurisprudenza della Cassazione ha “sia pure marginalmente, affrontato il tema della rinuncia alla proprietà degli immobili, in sostanza dandone sempre per scontata l’ammissibilità, salvo il rispetto dei requisiti formali”, rammenta la suprema Corte, che nella suddetta sentenza n. 23093/2025, pronunciandosi sui rinvii pregiudiziali disposti dal Tribunale di L’Aquila e dal Tribunale di Venezia, enuncia i seguenti principi di diritto:
“1. - La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.
2. - Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.”