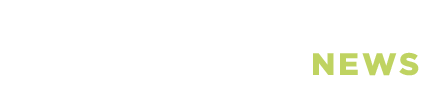Martedì 29 luglio in Commissione Ambiente della Camera, il Sottosegretario per le Infrastrutture Tullio Ferrante ha risposto all’interrogazione n. 5-04308 formulata dall’On. Santillo (M5S), con la quale si è chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “se intenda fornire dati e informazioni in merito agli effetti prodotti dal cosiddetto «decreto salva casa» rispetto agli obiettivi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, di riduzione del consumo di suolo, di ripresa del mercato immobiliare e all'impatto per gli enti locali sotto il profilo economico-finanziario, con particolare riferimento al numero delle pratiche edilizie generate in applicazione delle disposizioni introdotte dal citato decreto, rispetto agli anni precedenti, e ai proventi da oneri di urbanizzazione”.
Nell’interrogazione si osserva che la presenza, nel Decreto Salva-Casa (d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), di plurime disposizioni in parte retroattive, in parte di immediata applicazione e in parte di rinvio a una successiva disciplina regionale e comunale, avrebbe generato un crescente stato di incertezza e difformità interpretativa.
Inoltre, all’interrogante appare necessario modificare il Testo Unico dell’Edilizia sulla base dei valori costituzionali, “al fine di fornire soluzioni efficaci alla grave condizione di deprivazione abitativa del nostro Paese, attraverso l’urgente approvazione di un piano nazionale per l’abitare e l’avvio di processi di rigenerazione territoriale e urbana che perseguano la riduzione del consumo di suolo e la prevenzione rispetto ai frequenti e devastanti fenomeni di dissesto idrogeologico”.
La risposta del MIT
Nella sua risposta, il Sottosegretario ha osservato che la disciplina introdotta dal Decreto Salva-Casa, che prevede il rinvio ad una successiva disciplina regionale e comunale, non è dovuta a una scelta del Governo, quanto all’attuazione dei principi costituzionali ex art. 117. Il legislatore nazionale può solo limitarsi a dettare i principi fondamentali o al massimo i livelli essenziali delle prestazioni in materia edilizia; il rischio di disparità tra le diverse legislazioni regionali si concretizza solo qualora il legislatore locale si discosta o eccede i princìpi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Al contrario, permettere alle Regioni di adattare la normativa alle specifiche esigenze e peculiarità del proprio territorio, consente di calibrare meglio le politiche di governo dello stesso.
L’approvazione – in sede di Conferenza Unificata e sulla base delle Linee di Indirizzo del MIT – dell’accordo per l’aggiornamento della modulistica edilizia, rappresenta un passo significativo nell’attuazione del citato decreto-legge. A tal riguardo, il Sottosegretario ha menzionato i risultati positivi fatti registrare dal mercato immobiliare nel primo trimestre 2025 (oltre 172.000 abitazioni compravendute a livello nazionale) e la crescita parallela, seppur più contenuta, delle locazioni. Ha anticipato, come avvenuto durante il 5° Tavolo Casa, la “prossima” presentazione del disegno di legge delega per la riscrittura del Testo Unico dell’Edilizia ed il riordino della disciplina in materia di costruzioni, con l’obiettivo di riordinare una materia frammentata e complessa, e al contempo assicurare la semplificazione normativa tanto attesa dal comparto.
In conclusione, il Sottosegretario ha assicurato che il MIT sta portando avanti politiche abitative strutturali, inclusive e sostenibili, prevedendo due strumenti complementari: da un lato, l’adozione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale e, dall’altro, l’adozione del cosiddetto Piano Casa Italia. Per l’attuazione di questi strumenti, sono stati stanziati 660 milioni (di cui 100 milioni per i progetti pilota e 560 milioni per il Piano Casa Italia). Queste prime risorse potranno essere integrate da ulteriori contributi statali ed europei ma anche mediante l’individuazione di strumenti finanziari che favoriscano lo sviluppo del partenariato pubblico-privato e l’attrazione di capitali privati.