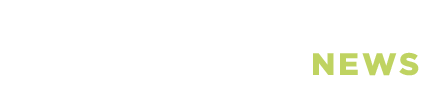Il 29 agosto scorso è entrata in vigore in Toscana la legge regionale 20 agosto 2025, n. 51 (pubblicata sul Bur n. 54 del 28 agosto) che modifica la legge regionale n. 65 del 2014 (norme per il governo del territorio) e recepisce il Salva Casa (decreto-legge 69 del 2024, convertito con modifiche dalla legge 105/2024) che ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Nella riunione di venerdì 17 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la predetta legge regionale della Toscana in quanto essa secondo il Governo “presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 1 e 2, e nell’articolo 36 che violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di 'determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale', di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e, inoltre, determina una lesione della competenza concorrente dello Stato in materia di 'governo del territorio', di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.
L'art. 3, comma 2 della legge toscana
La disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 2, della legge regionale in commento, inserisce nell’articolo 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 un comma aggiuntivo 2 bis, volto a recepire le semplificazioni in materia di mutamento di destinazione d’uso previste dall’articolo 23 ter, comma 1-quater, secondo e terzo periodo, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.
Il citato articolo 99, comma 2 bis, della legge regionale n. 65 del 2014, al secondo periodo, prevede che, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (i.e. tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dell’articolo 23-ter del TUE) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, “resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge”. Il titolo VII, capo I, della legge regionale n. 65 del 2014, da ultimo citato, disciplina in generale la tipologia e la corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso, con particolare riferimento al contributo di costruzione, comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. L’articolo 184, collocato all’interno del capo I, regola la determinazione degli oneri di urbanizzazione, stabilendo che gli oneri di urbanizzazione, da intendersi riferiti sia alle opere di urbanizzazione primaria che a quelle di urbanizzazione secondaria (comma 3), sono integralmente dovuti anche nel caso di mutamento di destinazione d’uso rilevante degli immobili (comma 1, lettera b)). Per effetto del combinato disposto dell’articolo 99, comma 2 bis, secondo periodo, e dell’articolo 184, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 65 del 2014, il mutamento di destinazione d’uso verticale rimane assoggettato non solo alla corresponsione del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ma anche alla corresponsione del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione primaria. Tuttavia, la legislazione statale demanda alla discrezionalità dell’ente regionale solo l’imposizione di oneri secondari relativi ai mutamenti di destinazione d’uso “verticali” di una singola unità immobiliare, non anche degli oneri di urbanizzazione primaria, in quanto la debenza di tali oneri è preclusa alla radice dal legislatore statale nel contesto della nuova impostazione dell’articolo 23-ter del TUE.
L’articolo 23-ter del TUE come modificato dal Salva Casa
Sul punto, il Governo ricorda che l’articolo 23-ter del TUE, come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2024, esprimendo un chiaro favor per l’agevolazione del mutamento di destinazione d’uso “verticale”, ha inteso introdurre semplificazioni sostanziali e procedurali orientate, tra l’altro, a ridurre gli oneri economici a carico del richiedente, per esempio escludendo l'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, il vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e, come accennato, facoltizzando, nei termini testé illustrati, il pagamento del contributo richiesto in relazione agli oneri di urbanizzazione secondaria. La ratio di siffatte misure di agevolazione, declinate al comma 1-quater, secondo e terzo periodo, del menzionato articolo 23-ter del TUE, è chiaramente rinvenibile nella circostanza che nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il mutamento avviene tendenzialmente in un contesto già urbanizzato, ove l’incremento del carico urbanistico si presume compensato o ridimensionato. L’imposizione di detti oneri, in quanto correlati alle opere di urbanizzazione necessarie all’utilizzo degli edifici, si risolverebbe, nell’ambito di contesti già urbanizzati (come sono le zone A), B) e C)), in una sostanziale duplicazione di costi a fronte dell’unicità dei servizi già predisposti nella zona interessata (e.g. strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, pubblica illuminazione). Muovendo da tali considerazioni, la formulazione dell’articolo 23-ter, comma 1-quater, del TUE va quindi intesa come preclusiva della possibilità di richiedere la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria per i mutamenti di destinazione d’uso “verticali”. Tale opzione è chiaramente confermata: a) dalla formulazione testuale del primo periodo, per cui il predetto mutamento di destinazione d’uso “è sempre consentito”, nel rispetto delle previsioni e dei criteri fissati dallo stesso comma 1-quater; b) dall’esplicita esclusione, contenuta nel medesimo comma, dell’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale e dei vincoli della dotazione minima di parcheggi, sopra richiamata; c) dalla formulazione testuale del secondo periodo, per cui “Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria”. Tale ricostruzione non è contraddetta dalla circostanza per la quale, in relazione ai medesimi mutamenti di destinazione d’uso, continua ad essere dovuto, ai sensi del terzo periodo dell’articolo 23-ter, comma 1-quater, del TUE, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ove previsto e nei limiti dati dalla legislazione regionale. Invero, le spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria (e.g. asili nido e scuole materne, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, attrezzature culturali e sanitarie) non possono automaticamente risolversi in una duplicazione di costi, in quanto sono funzionali alla vita di relazione degli abitanti della zona interessata.
Il punto D.2.1.4. delle Linee di indirizzo
L’interpretazione proposta trova ulteriore conferma in quanto riportato al punto D.2.1.4. delle “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)”, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 gennaio 2025, per le quali l’articolo 23, comma 1-quater, del TUE deve essere interpretato nel senso che, nei casi di mutamento di destinazione d’uso “verticale”, non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, ove ciò sia previsto dalla legislazione regionale. A fronte di ciò, la disposizione di legge regionale in esame mantiene immutata la disciplina previgente in punto di assolvimento degli oneri urbanistici e, pertanto, non recepisce i principi discendenti dalle disposizioni statali dianzi illustrate, le quali trovano in ogni caso applicazione diretta (cfr. articolo 23-ter, comma 3, TUE). La disciplina di cui all’articolo 23-ter del TUE pone principi fondamentali nella materia del governo del territorio e si configura, altresì, quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sul territorio nazionale, non potendosi ammettere – su tale aspetto di primario rilievo – una tutela frammentaria a livello territoriale. Si evidenzia quindi la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, oltre a porsi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di “governo del territorio”, violando così l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il medesimo articolo 3, comma 2, della legge regionale in oggetto inserisce nell’articolo 99 della legge regionale n. 65 del 2014 un ulteriore comma aggiuntivo 2 ter, il quale prevede che i comuni, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o della definizione della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, possano stabilire, oltre a specifiche condizioni, anche limitazioni in relazione ai mutamenti della destinazione d’uso della singola unità immobiliare, siano essi “orizzontali” (i.e. all'interno della stessa categoria funzionale) o “verticali” (nell’accezione sopra chiarita). L’articolo 23-ter del TUE, ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, sempre nell’ottica di agevolare il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale e tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale, ha riconosciuto la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare “condizioni”, quali misure di contingentamento delle richieste di mutamento di destinazione d’uso finalizzate a preservare l’assetto, lo sviluppo armonico del territorio e una distribuzione equilibrata dei carichi insediativi. Posto che i poteri pianificatori degli enti locali in materia di destinazioni territoriali e dei singoli edifici possono, in generale, estrinsecarsi nell’imposizione di condizioni, limitazioni o divieti, si può desumere che il legislatore statale, tenuto conto delle cennate esigenze di semplificazione sostanziale e procedurale, abbia appositamente – e consapevolmente – circoscritto il livello della regolazione comunale in materia di mutamento di destinazione d’uso all’apposizione di sole condizioni, quali criteri oggettivi e non discriminatori tali da non risolversi in limitazioni o restrizioni e, quindi, riferibili esclusivamente agli aspetti concernenti il mutamento di destinazione d’uso in sé e non anche alle modalità di realizzazione degli interventi nelle ipotesi di esecuzione di opere edilizie contestuale al mutamento stesso. La fissazione da parte degli enti locali di “limitazioni”, oltre che di “condizioni”, rischierebbe, infatti, di privare di contenuto la portata del nuovo articolo 23-ter del TUE, che a più riprese ricorre a formulazioni del tipo “sono sempre ammessi” o “è sempre consentito”, le quali sottolineano la volontà di fissare standard comuni sull’intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra le esigenze del singolo afferenti al diritto di proprietà e gli interessi pubblici connessi al governo del territorio. Tale interpretazione è suffragata anche da quanto riportato al punto D.2.1.1. delle menzionate “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)”, che chiariscono come i poteri pianificatori degli enti locali in materia di destinazioni territoriali potranno estrinsecarsi esclusivamente nell’imposizione di condizioni. Si evidenzia quindi la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, oltre a porsi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di “governo del territorio”, violando così l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 36 della legge toscana
L’articolo 36 della legge regionale in oggetto inserisce un nuovo articolo 252 septies nella legge regionale n. 65 del 2014, il quale differisce e condiziona l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del TUE in tema di mutamento di destinazione d’uso “verticale” di singole unità immobiliari, all’approvazione da parte dei comuni di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai suddetti mutamenti di destinazione d’uso. Nel richiamare quanto sopra illustrato in merito alle “limitazioni” si osserva che le disposizioni di cui al citato articolo 23-ter, commi 1-ter e 1-quater si atteggiano a principi fondamentali della materia che, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’articolo 23-ter del TUE (“Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione”), trovano in ogni caso applicazione diretta, con la conseguenza che le stesse operano anche in carenza delle “specifiche condizioni” definite di volta in volta nelle forme ritenute idonee dal comune. Peraltro, in considerazione del fatto che il citato articolo 252 septies prevede, al comma 2, che “La variante di adeguamento di cui al comma 1 è approvata entro due anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 20 agosto 2025, n. 51”, si rileva come l’applicazione delle disposizioni di principio di livello statale sia in tal modo differita per un considerevole lasso di tempo, tale da compromettere la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. La censura di illegittimità costituzionale rivolta al suddetto articolo 36 della legge regionale n. 51 del 2025 si estende anche all’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui, nel sostituire l’alinea del comma 2 dell’articolo 99 della legge regionale n. 65 del 2014 (“2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 252 septies […] del presente articolo”) fa riferimento all’articolo 252 septies di nuova introduzione per ribadire il differimento dell’applicazione delle semplificazioni in materia di mutamento di destinazione d’uso “verticale” all’avvenuta emanazione della pertinente regolamentazione comunale. Si evidenzia quindi la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, oltre a porsi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di “governo del territorio”, violando così l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Leggi anche: “Testo Unico Edilizia, anche la Toscana ha recepito le modifiche del Salva Casa”